Landing on Water (1986)
Se altri grandi degli anni Settanta, tra cui Don Henley, stavano avendo successo negli anni Ottanta con dischi moderni e pesanti come il synth, perché Neil Young non dovrebbe provarci? Una domanda a cui la risposta ovvia è: perché potrebbe suonare come Landing on Water, in cui canzoni perfettamente valide – non ultimo il devastante ritratto di David Crosby nella sua rovina cocainomane di Hippie Dream – sono state distrutte da una produzione sterile e antipatica.
Everybody’s Rockin’ (1983)
Come monumentale dito medio a un’etichetta discografica che aveva preteso un album “rock” da Young, il rockabilly e il R&B anni ’50 di Everybody’s Rockin’ è piuttosto impressionante. Come esperienza di ascolto, non tanto. La produzione digitale è orribile; la cover di Bright Lights Big City di Jimmy Reed è abissale.
Old Ways (1985)
Ha i suoi momenti, My Boy e Are There Any More Real Cowboys? tra questi, ma il disco country degli anni ’80 di Young – prodotto di nuovo, sembra, principalmente per infastidire la sua etichetta di allora, la Geffen – è iperprodotto, sciropposo e cliché al punto da suonare paternalistico. Il suo successivo corteggiamento del mercato conservatore di Nashville facendo dichiarazioni reazionarie nelle interviste è meglio trascurare.
Are You Passionate? (2002)

Questa collaborazione con Booker T and the MGs, che ha attirato molta attenzione per la bellicosa Let’s Roll, a tema post 11 settembre, è altrimenti dimenticabile: canzoni mid-tempo competenti e senza scopo; scarse di emozioni. Il sollievo arriva quando Crazy Horse entra graziosamente in scena su Goin’ Home.
Peace Trail (2016)
Non si può biasimare la recente etica del lavoro di Young, o il suo impegno politico, ma Peace Trail – il suo secondo album del 2016, in parte ispirato dalle proteste ambientali alla riserva di Standing Rock – è un pasticcio: songwriting abbozzato, idee musicali a metà tra cui un’esplosione di voci Auto-Tuned, testi platonici. Buona la title track, però.
Life (1987)
Dopo aver zoppicato Landing on Water con un’applicazione di synth e drum machine con la mano pesante, Young ha proceduto a zoppicare un album con i suoi vecchi amici Crazy Horse esattamente nello stesso modo. È esasperante perché le canzoni erano spesso grandiose, come evidenziato da Prisoners of Rock and Roll, un manifesto virtuale dell’approccio musicale primitivo dei Crazy Horse: “
Fork in the Road (2009)
“Sono una grande rock star, le mie vendite sono crollate / Ma ho ancora te – grazie”, offre Young nella title track. Non è niente se non è onesto, ma le sue vendite avrebbero potuto reggere meglio se i suoi ultimi album non avessero suonato sempre più sconnessi, con più pensieri nei loro messaggi – qui sull’inquinamento e la crisi finanziaria in corso – che nella musica.
Broken Arrow (1996)
C’è una teoria pervasiva che la musica di Young abbia sofferto dalla morte del suo produttore di lunga data, David Briggs, l’unico uomo che sembrava capace di tenerlo a freno e richiamare le sue idee meno ispirate. Certamente il primo album che ha fatto dopo la morte di Briggs sembrava tentacolare e senza direzione: lunghe jam dei Crazy Horse accanto a tracce dal vivo di qualità bootleg.
Paradox (2018)
L’incoerente film di Darryl Hannah su Young e i suoi ultimi giovani collaboratori, Promise of the Real, è una prova di resistenza che rivaleggia con l’analogo documentario senza meta Journey Through the Past del 1972, ma la colonna sonora – un patchwork di passaggi strumentali, outtakes e registrazioni dal vivo – è abbastanza coinvolgente e piacevole mentre va alla deriva, anche se chiaramente solo gli irriducibili di Young devono fare domanda.
Colorado (2019)
L’ultimo di una serie di album mediocri con i Crazy Horse, Colorado presenta alcune performance incendiarie nello stile patentato della band – c’è un momento a metà di She Showed Me Love in cui il batterista Ralph Molina sembra smettere di suonare per errore – ma presenta anche alcuni testi politici dolorosamente banali e non molto in termini di brani decenti.
Storytone (2014)

L’indecisione afflisse Storytone, che Young pubblicò in tre versioni: una orchestrata, una spogliata, una con un po’ di entrambe. Forse si è reso conto che il concetto iniziale dell’album, Neil Young come crooner, non funzionava del tutto, oscillando tra l’affascinante (I Want to Drive My Car, alimentata dalla big band) e lo schlocky (Tumbleweed).
Prairie Wind (2005)
Il meno attraente degli album di Young nel filone Harvest, Prairie Wind è ancora uno dei più forti album degli ultimi tempi. L’umore autunnale e riflessivo di He Was the King e This Old Guitar sono stati presumibilmente influenzati dalla morte di suo padre e dal contatto di Young stesso con la mortalità dopo un aneurisma al cervello.
Silver & Gold (2000)
Un altro album nel filone country-rock di Harvest. I punti salienti sono alti – la cupa chiusura Without Rings è particolarmente bella – ma c’è molto riempimento, e la nostalgia tinta di rosa dell’inno di Young alla sua ex band, Buffalo Springfield Again, è particolarmente liquida.
Greendale (2003)
Salutato da alcuni come un ritorno alla forma – che significava semplicemente un miglioramento del suo poco brillante predecessore, Are You Passionate? – Greendale era l’opera rock di Young, un titolo grandioso che sembrava antitetico al suo suono ruvido e bluesy. Il songwriting è troppo irregolare per sostenere l’interesse: Be the Rain e Bandit sono grandi; Grandpa’s Interview interminabile.
Arc (1991)
È stato Thurston Moore dei Sonic Youth a suggerire a Young di pubblicare un album dal vivo interamente composto dalle introduzioni e dalle outro cariche di feedback delle sue performance dal vivo. Mescolato in studio in una traccia di 35 minuti, non è una dichiarazione così provocatoria come Metal Machine Music di Lou Reed, ma vale la pena di ascoltarlo almeno una volta.
The Monsanto Years (2015)
L’ultima backing band di Young, i Promise of the Real, suona infuocata qui, e Young stesso è visibilmente livido, ma The Monsanto Years è un altro album che sembra affrettato al punto che la scrittura effettiva è stata trascurata. I testi – piovono fuoco sugli OGM – spesso sembrano più degli sproloqui su un blog messi in musica che canzoni.
Trans (1982)
Ispirato dal figlio tetraplegico Ben, un concept album elettronico di Neil Young con voci vocali fu una mossa incredibilmente audace, tanto che Young lo riempì di materiale più diretto. Il risultato finale fu un curioso pasticcio; la bellezza di Transformer Man fu pienamente rivelata solo quando Young la suonò acusticamente su MTV Unplugged nel 1993.
Hawks & Doves (1980)
Distratto dalle lotte familiari, il seguito del classico Rust Never Sleeps di Young fu una raccolta disordinata di brani country buttati insieme e ritagli vari. Hawks & Doves è selvaggiamente irregolare, la sua title track è semplicemente terribile, ma le parti buone – il sinistro Captain Kennedy, la bellissima Lost in Space, la lunga allegoria di The Old Homestead sulla sua carriera – sono fantastiche.
Mirror Ball (1995)
Chiaramente orgoglioso della sua etichetta di “padrino del grunge” – la combinazione di scioltezza e intensità dei Crazy Horse fu un’influenza chiave sul suono – Mirror Ball vide Young collaborare con i Pearl Jam. I risultati sono stati solidi, ma mai abbastanza esplosivi o taglienti da impedirti di desiderare che avesse scelto di lavorare con i suoi ex compagni di tournée Sonic Youth, che avrebbero potuto spingerlo di più.
Chrome Dreams II (2007)
Classico Neil: 30 anni dopo aver rifiutato di pubblicare un album chiamato Chrome Dreams, ne fa uscire un seguito. Chrome Dreams II è imperniato su una traccia, la sorprendente Ordinary People di 18 minuti. Registrata nel 1987, getta la maggior parte del materiale più recente dell’album sotto una luce inesorabile, ma la sfibrata e ultra-distorta Dirty Old Man regge il confronto.

Americana (2012)
Un album in gran parte composto da canzoni popolari drammaticamente riassemblate – Clementine e Oh Susanna tra queste – Americana è sporadicamente grande, occasionalmente sciatta e talvolta genuinamente sorprendente. Abbastanza improbabilmente, si conclude con Crazy Horse che imposta God Save the Queen, come l’inno nazionale inglese, non la canzone dei Sex Pistols.
Neil Young (1968)
“Overdub city”, protestava Young del suo debutto solista, e non aveva tutti i torti. È pieno di canzoni fantastiche che Young avrebbe ripetutamente ripreso dal vivo – The Loner, Here We Are in the Years, The Old Laughing Lady – ma spesso geme sotto il peso degli elaborati arrangiamenti di Jack Nitzsche. Da questo punto in poi, Young avrebbe premiato la semplicità e la spontaneità.
Psychedelic Pill (2012)
I Crazy Horse si sono fatti un nome suonando jam estese, un approccio che gli Psychedelic Pill hanno portato all’estremo: l’opener qui, Driftin’ Back, va avanti per buona parte di mezz’ora. Se giustifichi quella lunghezza è un’altra questione, anche se Ramada Inn, che arriva a soli 16 minuti, è formidabile.
Dead Man (1995)
La prima colonna sonora di Young, Journey Through the Past del 1972, era un’accozzaglia di registrazioni live e outtakes che riuscì ad inorridire i fan che pensavano fosse il seguito di Harvest. Eseguito dal vivo su un montaggio grezzo del surreale western Dead Man di Jim Jarmusch, è qualcos’altro: un lungo, crudo, occasionalmente violento strumentale di chitarra.
American Stars ‘N Bars (1977)
Il più debole degli album in studio di Young negli anni Settanta, American Stars ‘N Bars combinava brani presi dall’allora inedito Homegrown con registrazioni casalinghe lo-fi (la stranamente inquietante Will to Love), country-rock plumbeo e un classico indiscusso dei Crazy Horse: Like a Hurricane (anche se ci sono versioni dal vivo migliori).
A Letter Home (2014)
Sembra una novità – Young che registra cover in una cabina di registrazione in vinile del 1947 di proprietà di Jack White – ma A Letter Home funziona, saltando da canzoni che Young avrebbe suonato come cantante folk in un caffè, come Needle of Death di Bert Jansch, a una versione ossessionante di My Hometown di Bruce Springsteen.
Living With War (2006)
Registrato e pubblicato rapidamente, sostenuto da un coro di 100 voci, la filippica contro la guerra in Iraq Living With War trova Young che suona pieno di energia per l’urgenza della sua impresa e, si sospetta, per il furore che deve aver saputo che avrebbe causato. Un successivo tour di Crosby Stills Nash & Young, basato su questo materiale, fu accolto da fischi e proteste da parte dei loro fan più conservatori.
Re-ac-tor (1981)
Un album dei Crazy Horse macinante, oscuro e ripetitivo (deliberatamente; è influenzato da un estenuante programma di trattamento subito dal figlio di Young), Re-ac-tor è un lavoro duro, a volte poco ispirato e a volte magnifico, come nel feroce fragore di Surfer Joe e Moe the Sleaze e nella conclusiva Shots.
Harvest (1972)
Che l’enorme successo commerciale di Harvest abbia scatenato in Young un attacco di comportamento ostinato, persino contrarian, non è così inspiegabile: presumibilmente sapeva che il suo più grande album non era nemmeno lontanamente vicino al suo meglio. Le canzoni variano da fantastiche (la title track; Words) a dimenticabili, mentre gli arrangiamenti sono brillanti ma a volte esagerati, come in A Man Needs a Maid.
This Note’s for You (1988)
Di gran lunga il più riuscito degli esperimenti di genere di Young negli anni ’80, e una sorta di rinascita creativa, l’album bluesy R&B di Young è meglio conosciuto per la sua title track, un’eviscerazione della crescente propensione del rock degli anni ’80 per le sponsorizzazioni aziendali, ma i suoi momenti migliori sono sottili e discreti: l’atmosferica Twilight, la malinconia delle piccole ore di Coupe De Ville.
Hitchhiker (1976)
Il suono di Young da solo in studio, “aprendo il rubinetto”, come dice David Briggs, e lasciando sgorgare nuove canzoni (quasi tutte finite per essere riregistrate altrove). Il fatto che Young sia udibilmente, eroicamente fatto durante tutto l’album aggiunge solo il suo fascino intimo.
Le Noise (2010)
Prodotto da Daniel Lanois, questo è il miglior album di Young del 21° secolo, e lo ha portato in un posto nuovo. Lanois ha aggiunto l’occasionale e disorientante loop di nastro mentre Young si accompagna con la chitarra elettrica distorta, che sta chiaramente suonando a volume spacca orecchie. Portare questa freschezza di approccio a un album solista di cantautori ha prodotto del materiale forte.
Harvest Moon (1992)
Harvest Moon è meglio del classico album a cui il titolo fa riferimento, e di cui ha riassemblato i musicisti. Il suono si adatta alle canzoni, che sono malinconiche e striate di nostalgia. La title track, il cui riff è stato rubato da Walk Right Back degli Everly Brothers, è un inno genuinamente bello al matrimonio e all’amore duraturo.
Ragged Glory (1991)
I Crazy Horse nel loro momento più allegramente primitivo – Young sembra abbia registrato la sua voce in piedi su un mucchio di letame di cavallo – si scatenano attraverso standard garage-rock (Farmer John dei Premiers), jam tumultuose (Love and Only Love, Mansion on the Hill) e paeans ai loro stessi limiti (F!#*in’ Up). Un’esplosione dall’inizio alla fine.
Homegrown (1975)
“A volte la vita fa male”, ha scritto Young per spiegare la tardiva pubblicazione di Homegrown nel 2020, 45 anni dopo averlo registrato in seguito alla sua separazione dall’attrice Carrie Snodgrass. E’ certamente abbattuto, il suo tono è stabilito dall’opener Separate Ways, ma è anche Young all’apice dei suoi poteri, scrivendo canzoni fragili e belle.
Comes a Time (1978)
Il dolce album country-rock che la sua casa discografica avrebbe senza dubbio voluto pubblicare come seguito di Harvest, Comes a Time è molto meglio del suo predecessore spirituale. È più ruvido intorno ai bordi – i Crazy Horse si fanno vedere nelle meravigliose Lotta Love e Look Out for My Love – e ospita una coppia di classici di Young, tra cui la title track.
Freedom (1989)
Dopo i confusi anni ’80, lo stupefacente ritorno di Young alla piena e furiosa potenza era perfettamente in tempo, in sintonia con il nascente movimento grunge che lui stesso ha contribuito a ispirare. L’ampiamente fraintesa Rockin’ in the Free World fu il successo, ma Freedom è pieno di tracce assassine, dalla lunga Crime in the City (Sixty to Zero) con i fiati a una feroce cover di On Broadway.
Sleeps With Angels (1994)
La lettera d’addio di Kurt Cobain citava un testo di Young, con grande orrore del suo autore; la title track di Sleeps With Angels era la sua risposta angosciata. Altrove, questo è tetramente avvincente e raccapricciante come il suo lavoro di metà anni 70, con Crazy Horse in forma sorprendentemente silenziosa. Piece of Crap, nel frattempo, introduce Young come un irritabile refusenik di mezza età, un ruolo che avrebbe spesso abitato.
Time Fades Away (1973)
Solo Neil Young avrebbe seguito la sua svolta commerciale con un caotico souvenir audio-verità di un tour disastroso. Ma Time Fades Away non è solo un gesto di “screw-you”, è assolutamente avvincente. Le canzoni – lo scalpitante frastuono hippy di Last Dance, la fragile ballata per pianoforte The Bridge e l’autobiografica Don’t Be Denied – sono incredibili, potenziate dalle performance stracciate.
Zuma (1975)
Più leggero nei toni rispetto alla “trilogia del fosso” (Time Fades Away, Tonight’s the Night e On the Beach) che l’ha preceduto, Zuma ha riunito Young con un rivitalizzato Crazy Horse, scatenando la gloriosa evocazione di Barstool Blues di una mente ubriaca che vaga e la cupa e maestosa epica storica Cortez the Killer. E la sua lambente chiusura Through My Sails è l’ultima vera grande canzone che Crosby Stills Nash & Young ha pubblicato.
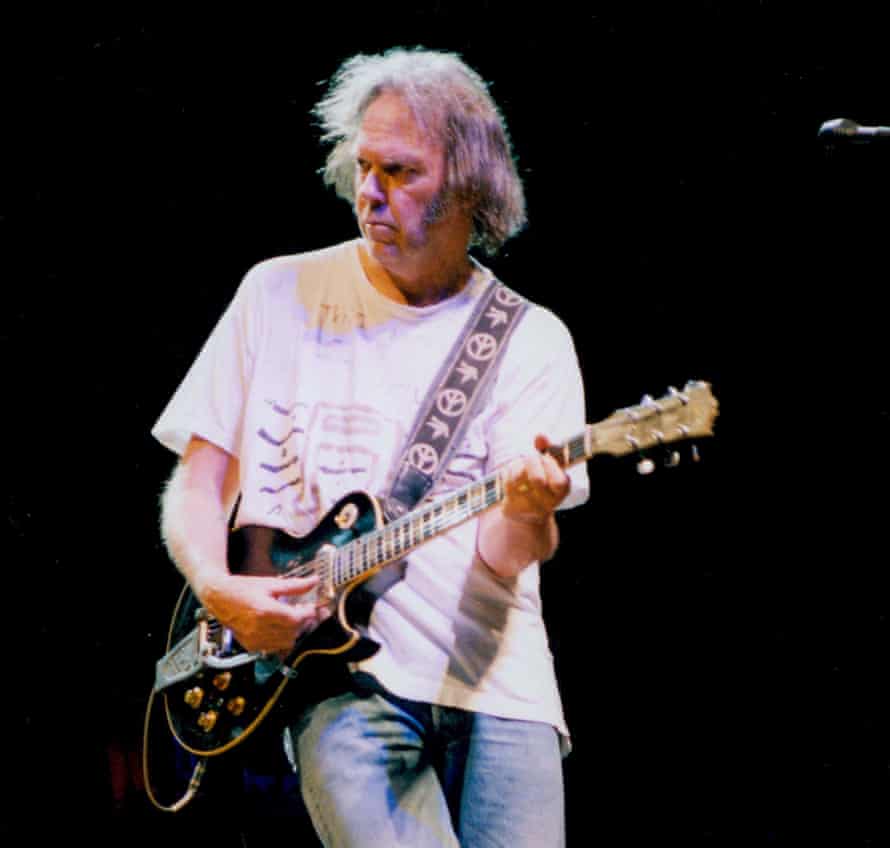
After the Gold Rush (1970)
After The Gold Rush sembra l’album di Young del mattino dopo gli anni ’60, ma a differenza del tono consolatorio di Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, è scarno, tormentato e toccante. Tra i problemi di relazione, c’è il disastro ecologico, il razzismo e Don’t Let It Bring You Down, che, ha notato Young, era “garantito che ti porterà giù”.
On the Beach (1974)
Desperante e sconsolato, ma con una bella musica: il luccicante piano elettrico di See the Sky About to Rain, l’epica chiusura acustica Ambulance Blues (“You’re all just pissing in the wind”, conclude), il rock stonato e nebbioso della title track. Per contrasto, c’è Revolution Blues, un feroce, spietato ritratto della vecchia conoscenza di Young, Charles Manson.
Tonight’s the Night (1975)
La risposta di Young, impregnata di tequila e senza filtri, alla morte del chitarrista dei Crazy Horse Danny Whitten e del loro roadie Bruce Berry è un ascolto straziante e straordinariamente potente, la raucedine ubriaca delle performance corrisponde alla cruda emozione delle canzoni. Il punto in cui la voce di Young si incrina durante Mellow My Mind è forse il più crudo e potente del suo catalogo.
Everybody Knows This Is Nowhere (1969)
Il debutto di Young con i Crazy Horse è un album incredibile: la pura potenza delle sue canzoni e del suo suono; il riff assassino di Cinnamon Girl; il modo in cui l’esecuzione delle jam estese Down By the River e Cowgirl in the Sand incarna la loro angoscia lirica, tenendo l’ascoltatore completamente avvinto anche quando superano i 10 minuti.
Rust Never Sleeps (1979)
La linea tra gli album dal vivo e quelli in studio di Young è sempre stata flessibile. Rust Never Sleeps fu registrato sul palco nel 1978, poi sovrainciso. In verità, la maggior parte dei suoi album degli anni 70 potrebbero essere considerati i suoi migliori – ha mantenuto uno standard notevolmente alto – ma Rust Never Sleeps offre un perfetto riassunto di tutto ciò che lo rende grande, la sua qualità forse stimolata dal movimento punk a cui fa riferimento su Hey Hey, My My (Into the Black) e, più ellitticamente, su Thrasher. La sequenza di canzoni acustiche del primo lato è mozzafiato, e i Crazy Horse infuriano in stile fragoroso sul secondo lato, dove si trova la straziante saga di violenza, morte e legami familiari di Powderfinger – probabilmente la sua più grande canzone.